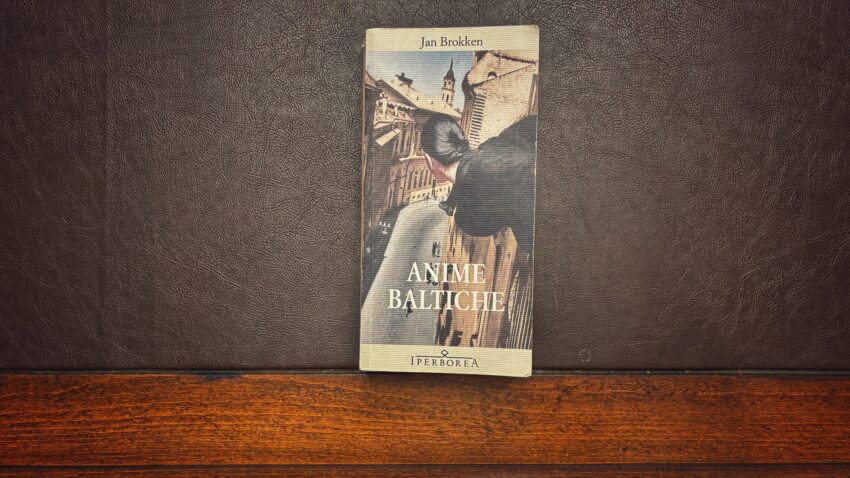Già in un precedente post, di qualche mese fa, dichiarai la mia stima per Jan Brokken, scrittore e giornalista olandese, le cui opere hanno il dono di accendere la mia curiosità su temi che non conosco, o di cui ho solo nozioni sommarie. La lettura di Anime Baltiche ha ulteriormente rafforzato il giudizio: la passione con cui l’autore descrive le sue esplorazioni in quelle terre, attraverso i personaggi celebri che vi hanno trovato i natali, è contagiosa, quasi un cristallo attraverso cui la luce assume mille sfaccettature, ognuna delle quali suggestiva. Impossibile leggere questo libro senza provare il desiderio di recarsi in quei luoghi, alla ricerca delle atmosfere evocate.
Brokken è affascinato dalla fierezza dei baltici, ma chiarisce “L’orgoglio non ha niente a che vedere con il nazionalismo, lo sciovinismo e l’arroganza. Essere orgogliosi del proprio paese significa credere in tutto ciò che lo rende speciale, diverso, unico. Significa avere fiducia nella propria lingua, nella propria cultura, nelle proprie capacità e nella propria originalità. Questo orgoglio è la risposta adeguata alla violenza e all’oppressione.” Riassumendo in un solo paragrafo la bellezza di un popolo che vuole essere comunità, una caratteristica che vedo progressivamente annacquarsi altrove, purtroppo.
Le vite ricostruite nelle oltre 470 pagine del volume, edito da Iperborea, restituiscono intense fotografie di periodi storici drammatici. Le due guerre mondiali, gli avvenimenti che le hanno precedute e la ferocia che ha accompagnato questi anni incidono pesantemente sull’esistenza di molti dei protagonisti, con echi che risuonano sinistri anche ai giorni nostri. La citazione del regista Sergej Ejzenstejn ne sottolinea l’impegno politico “A livello biologico siamo tutti mortali. Ma diventiamo immortali grazie a ciò che riusciamo a fare per la società. In questo modo ci proiettiamo nel futuro, passando la fiaccola del progresso sociale da una generazione all’altra.” Ma gli orrori della guerra, i massacri, la pulizia etnica sono elementi ricorrenti anche in un recente passato, è il caso del capitolo dedicato a Loreta Asanaviciute, giovane ferita a morte nel 1991, travolta da un carrarmato, manifestando per contrastare l’invasione sovietica nella Lituania indipendente.
Ogni vicenda narrata prende, infatti, il via dalle note biografiche che si intrecciano con i grandi eventi storici, un costante dialogo fra le due dimensioni che consente di capire meglio la personalità dei protagonisti. Di frequente i legami familiari difficili, i contrasti con le figure genitoriali, sono la molla per il successo personale, per prendere le distanze dalle proprie radici, che, in quanto tali, inevitabilmente riaffiorano. Una frase mi ha fatto riflettere a lungo: scrivendo del violinista Gidon Kremer, ma anche di se stesso, l’autore afferma “è difficile crescere all’ombra di una guerra che non si è vissuta” evidenziando come le sofferenze patite durante la guerra dai padri abbiano inciso sull’infanzia dei figli.
Ma sono diversi i passaggi che ho sottolineato a matita leggera fra le pagine: di Hannah Arendt si legge che “ti spinge a riflettere, a farti un’idea tua e, cosa più importante, ad assumerti le tue responsabilità.” Responsabilità, parola desueta e concetto ancora meno praticato. C’è un continuo richiamo a ciò che l’insensato bisogno di distruzione degli uomini provoca, l’opera Le cri di Jacques Lipchitz, risente di un evento accadutogli da studente, due giorni passati a nascondersi dalle persecuzioni di Bialystok, mentre attorno a lui si compiva il massacro di centinaia di ebrei; per tacitare le urla della folla inferocita, che dopo vent’anni risuonano ancora nella sua mente, crea una scultura che “dalle tenebre aveva fatto uscire per miracolo la luce.” L’inquietudine, lo sradicamento, la nostalgia sono elementi che attraversano l’esistenza di molti, alcuni dopo una vita di successi si arrendono alla depressione che hanno invano tentato di celare dietro a traguardi sempre più ambiziosi, anime che, pur frantumate, si sono spese per lasciare il proprio contributo al mondo.
Menzione speciale al capitolo che vede protagonista il compositore Arvo Part, in cui si riporta una sua dichiarazione sul progresso nell’arte, di cui Part dubita, poiché la modernità di alcuni autori non sparirà mai “Non perché, in termini assoluti, sia migliore della musica contemporanea, il segreto sta nella domanda: con quanta profondità il suo autore è riuscito a esprimere la propria esistenza e, più in generale, la totalità della vita, le sue gioie, i suoi dolori, i suoi misteri?” Leggendo ho avuto la curiosità di ascoltare i brani citati rimanendone incantata, musica che nutre lo spirito.
L’ennesimo regalo di un grandissimo scrittore che sa trasportare il lettore con sé nei suoi ripetuti soggiorni in Estonia, Lettonia e Lituania, sino a Kaliningrad, “perché viaggiare, insieme a leggere e ascoltare, è sempre la via più utile e più breve per arrivare a se stessi”.